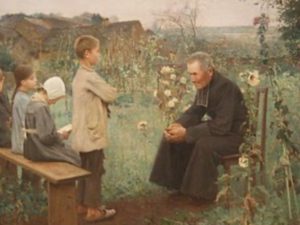
19 novembre
Affronterò il tema di questa sera utilizzando l’episodio narrato in Genesi 22 ripercorrendo, nel cammino del tempo, l’evoluzione del culto a Dio.
Dicevamo la volta scorsa che spesso facciamo confusione tra il tempo kronos ed il tempo kairos restando impelagati nel kronos, ripetitivo come le ore, le settimane, le stagioni, …, che non ci permette di fare nessuna evoluzione inserendoci nel piano divino, che chiamiamo economia della salvezza.
Così il nostro atto di culto a Dio si rigira nel kronos. Pensiamo all’anno liturgico. Al centro ci sta il Triduo Pasquale, che celebriamo per 50 giorni e a cui ci prepariamo con il tempo di Quaresima. L’altro evento che celebriamo è l’incarnazione di Gesù a cui ci prepariamo con il tempo di Avvento. Tra dieci giorni si chiude un anno liturgico e ne inizia uno nuovo. Il culto a Dio si ripresenta nel kronos, difficilmente nel kairos che dovrebbe accompagnarci alla piena sintonia con Dio, riconciliati con noi stessi, col prossimo con tutto il creato.
Se rileggiamo i primi due capitoli della Genesi, dove si racconta la creazione del mondo non si fa riferimento ad atti di culto. L’uomo vive e gode della piena armonia con Dio. Poi il peccato distrugge questa armonia ed appena l’uomo e la donna escono dal giardino di Dio e cominciano a lavorare la terra, la nuova generazione comincia il rituale dei sacrifici. L’autore sacro ci racconta di Caino e Abele. Caino offre frutti del suolo in sacrificio al Signore, Abele offre i primogeniti del suo gregge e il loro grasso. Il Signore gradisce Abele e la sua offerta, ma non gradisce Caino e la sua offerta (cf. Gen 4,2-8).
(Gen 22, 1 – 18)
La relazione dell’uomo con Dio, basata sull’offerta, è rovinata dal peccato. L’offerta di Caino non è gradita al Signore perché Caino è cattivo e fa una offerta in modo cattivo.
Il mondo dei sacrifici non è automaticamente buono, dipende dal cuore di chi offre, dall’armonia di chi offre con la volontà di Dio.
L’atto di culto, l’azione sacra mi permettono di entrare in relazione con Dio, che è separato da noi. Per essere gradito devo dargli qualche cosa. Il sacrificio risponde a questa dinamica: salire come il fumo dell’olocausto a Dio per incontrarlo in qualche modo e ottenere la sua benedizione.
I popoli primitivi ai tempi di Abramo usano offrire alla divinità qualche persona umana, addirittura i propri figli. Nella Bibbia si raccontano situazioni del genere, che i profeti condannano, ma che di fatto avvenivano.
Nell’ambiente di Abramo, sacrificare il proprio figlio era un gesto religioso e perciò la tentazione di Abramo è quella di essere molto religioso, di essere talmente religioso da arrivare al punto di sacrificare il figlio.
Ad Abramo viene chiesto l’olocausto del figlio, ma Dio interviene. Il sangue della vittima sacrificale sostituisce la vita dell’offerente che si è allontanato da Dio.
Successivamente la tradizione profetica e sapienziale rilegge il rituale dei sacrifici come adesione totale del cuore a Dio.
Il regalo è una cosa bella, fa piacere riceverlo, ma può servire per corrompere qualcuno e così il regalo diventa cattivo. La bontà del regalo dipende dall’atteggiamento con cui lo facciamo. E questo vale anche per l’intenzione con cui facciamo a Dio un sacrificio.
Ci ricorda il Salmo 50
Tu non gradisci il sacrificio; se offro olocausti, tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio;
un cuore contrito e affranto tu, o Dio, non disprezzi.
Nella tua bontà fa’ grazia a Sion, ricostruisci le mura di Gerusalemme.
Allora gradirai i sacrifici legittimi, l’olocausto e l’intera oblazione.
La rivelazione biblica è un grande pedagogo. I concetti non vanno divorati, ma assimilati. A poco a poco.
Siamo partiti dal sacrificio degli animali uccisi e bruciati per giungere al sacrificio del cuore, cioè della intenzione, della volontà. Sembrava che Dio si accontentasse di un agnello o di un vitello per capire che Dio desidera il cuore, cioè l’essenza della persona, la sua intelligenza, la sua volontà, la sua adesione personale.
Manca l’ultimo tassello perché l’atteggiamento personale non basta, da solo, a metterci in piena comunione con Dio, e a superare il nostro naturale limite del peccato.
Se non c’è offerta che possa avvicinarci a Dio, che cosa offriremo al Signore? Tutti, dal primo all’ultimo, siamo incapaci di creare una buona relazione con Dio e la stessa offerta dei sacrifici è un tentativo di corruzione, per tappare la bocca a Dio.
Ci vuole l’offerta del cuore, ma chi è capace di offrire davvero il cuore, chi è capace di una relazione sincera, profondamente buona con il Signore?
L’offerta del cuore è insufficiente e incapace, è sempre parziale perché l’unica azione buona è il dono che Dio fa di sé. L’incarnazione ci dice che Dio rovescia il discorso. Nel sacrificio di Gesù non è l’uomo che
dà qualcosa a Dio, ma Dio dà sé stesso all’uomo.
Gesù è il dono di Dio, è Dio che si dona in persona, ed è un sacrificio vivente.
Papa Benedetto XVI richiamando la lettera ai Romani al cap. 12: “Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio; è questo il vostro culto spirituale” ci avverte che mentre il sacrificio esige di norma la morte della vittima, Paolo ne parla invece in rapporto alla vita del cristiano.
Paolo suppone sempre che noi siamo divenuti “uno in Cristo Gesù” (Gal 3,28), che siamo morti nel battesimo (cfr Rm 1) e viviamo adesso con Cristo, per Cristo, in Cristo. In questa unione, e solo così, possiamo divenire in Lui e con Lui “sacrificio vivente”, offrire il “culto vero”.
Gli animali sacrificati avrebbero dovuto sostituire l’uomo, ma non potevano. Nella comunione con Cristo, realizzata nella fede e nei sacramenti, diventiamo, nonostante tutte le nostre insufficienze, sacrificio vivente e così si realizza il “culto vero”.
Gesù accetta liberamente il sacrificio. Non offre un animale al suo posto, ma offre sé stesso, il proprio sangue, diventa cosi strumento di riscatto e di redenzione, di consacrazione e di fondazione della nuova ed eterna alleanza.
Nella vigilia della sua passione Gesù inventa un rito nuovo, inventa un nuovo sacrificio che anticipa la propria morte. Successivamente il memoriale di questo sacrificio sarà non solo un ricordo della sua morte, ma il mezzo perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
Il sacrificio della nostra vita è lasciare che il Signore comandi nella nostra esistenza, ne prenda il controllo, e così noi ci abbandoniamo a lui, rinunciando al nostro “io”.
Se ci deve essere un olocausto deve essere quello dell’io, dell’io vecchio perché possa rinascere l’io nuovo perfettamente conforme a Cristo.
Anche questa sera voglio concludere con un pensiero del nostro Santo Padre Francesco di Paola:
“Ricordatevi della Passione del nostro Signore e Salvatore e pensate quanto infinito fu quell’ardore che discese dal cielo in terra per salvarci; che per noi soffrì tanti tormenti e subì la fame, il freddo, la sete, il caldo e ogni umana sofferenza, nulla rifiutando per amor nostro e dando esempio di perfetta pazienza e di amore perfetto.”
di F. Romeo (Le catechesi del martedì sera nella Chiesa di San Francesco di Paola a Palermo). (tratto da App Charitas del 21 novembre 2019)

